

Ognuno mangia solo in zona rossa, una zuppa di verdura ed è subito Masterchef. C’è ancora spazio nell’Italia della pandemia per l’opulenza degli show di cucina? Davanti alla mensa popolare c’è la fila, ma i cuochi sono ovunque e battono le canzonette. La finale del reality culinario ha avuto numeri in crescita, Sanremo invece cala drasticamente, nonostante la bravura di Fiorello. Eppure lo spirito di quaresima c’è per tutti. Perché, allora, la formula di Masterchef continua a convincere e il palco dell’Ariston deprime? Il pubblico, per inteso, mancava da ambo le parti, per scelta o necessità.
Partiamo da Masterchef. Il format britannico, nato la bellezza di trent’anni fa, ha portato nell’olimpo televisivo un’arte che prima di tutto è un mestiere. Per qualcuno avere tanti cuochi in tv ha rappresentato un vero e proprio reato di lesa popolarità, ma nell’immaginario collettivo, dove ognuno ha un amico o un parente nella ristorazione, sui palchi nonostante tutto ci si diverte, in cucina e in sala si suda.

Questione di età. Sanremo è lì da sempre, Masterchef Italia ha compiuto dieci anni. Il programma di Sky ha un livello produttivo immenso, luci cinematografiche e tagli di montaggio ogni due secondi. Meglio di un live, zucchero per gli occhi.
A Masterchef i concorrenti appartengono a tutte le classi sociali, ma i giovani sembrano giovani. A Sanremo capivi subito che il cantante più giovane ha cinquant’anni nel cuore e segretamente ambisce a fare il notaio, anche se pensa di scandalizzarti coi vestitini.
Negli anni precedenti hanno vinto Masterchef medici e avvocati, ma il pubblico tifa sempre per chi è in cerca di riscatto.
La parola che viene usata di più è “passione”, un termine che qui va inteso in senso religioso, di sacrificio e rinascita, dolorosa umiltà e resurrezione. Ai concorrenti si chiede preparazione, studio, lacrime e sangue. Letteralmente, quando scappa il coltello sulla falange o si rimembrano le umili origini.
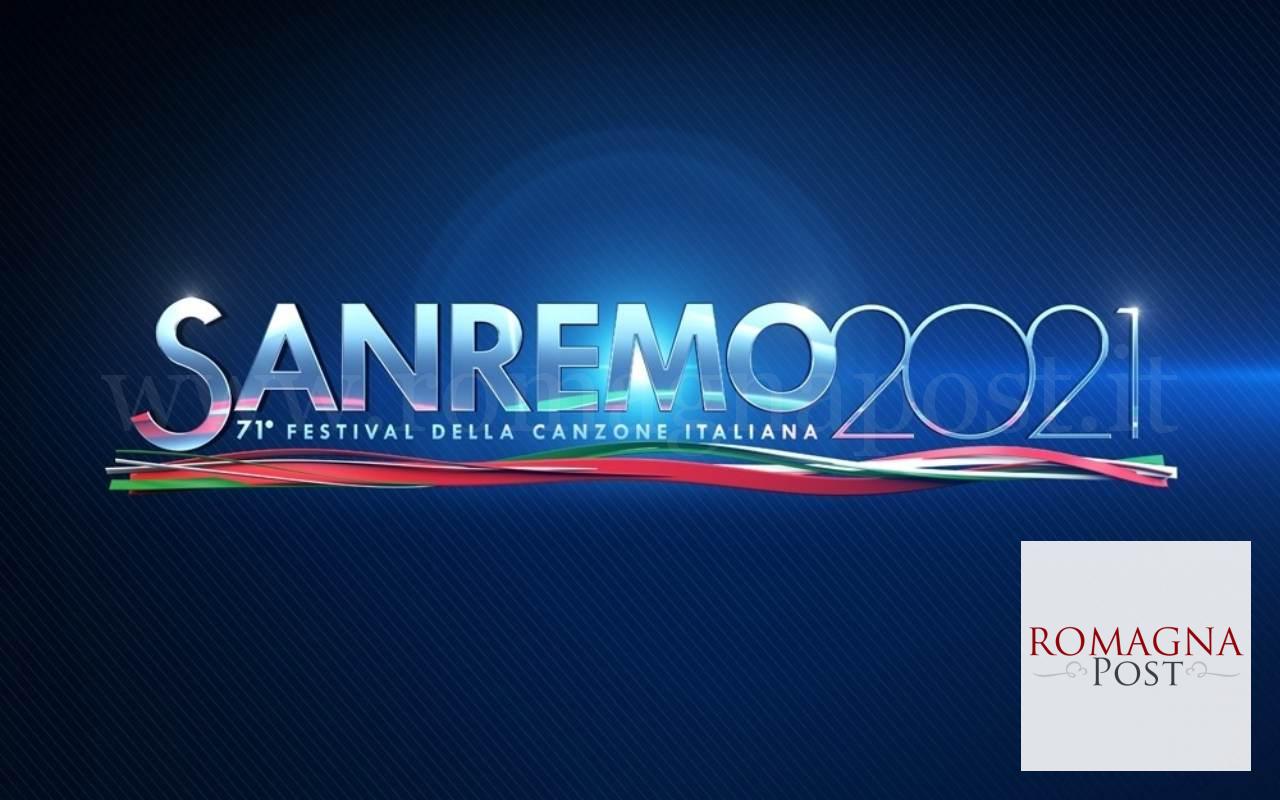
Si sente che Masterchef non è un reality, è un programma internazionale molto scritto e scritto benissimo, che riesce a creare un thriller con i maltagliati.
Sanremo è la digestione difficile di una cultura popolare che rimastica se stessa da troppo tempo e non si riesce più a percepire come autentica. La finta allegria, i finti giovani, la finta trasgressione, i finti talenti. La cosa più vera sembravano gli applausi registrati.
A Masterchef le regole della competizione appaiono chiare e severe. I tre giurati di turno rappresentano le divinità giudicanti, i guardiani della porta di un paradiso fatto di popolarità, show cooking e comparsate nei programmi di cucina. Sono archetipi narrativi e regioni geografiche in cui riconoscersi. Il bonario buongustaio del sud. L’emiliano estroso. Il settentrionale algido e un po’ british che ha preso il posto dell’americano incazzoso e un po’ italiano. Anche i partecipanti sono caselle da riempire. I ruoli sono sempre quelli, ma si fa finta di non riconoscerli, per buona educazione e amore della bidimensionalità.
ll pensionato, il professionista di grido, la casalinga, il giovane scapestrato, il creativo, il rappresentante “arcobaleno”, quello di bella presenza, l’imprenditore, il disoccupato, lo studente, il sottoproletario, lo straniero integrato o da integrare, il sopravvissuto, l’antipatica supponente, quello che parla solo in dialetto e fa ridere tutti. I piatti hanno tutti un nome e non posso fare a meno di pensare che da quando vedo Masterchef la mia cucina di sussistenza non può fare a meno di di “paste all’olio alla sperindio” e “sfida solitaria alla carne in scatola”.
A confronto Sanremo sembra un concorso ministeriale con le raccomandazioni, la prova scritta e la commissione in cui primeggia il cognato della sorella dell’assessore. Hanno vinto i Maneskin e nessuno sa spiegare esattamente perché, se non con analisi che sembrano quelle del sistema elettorale svizzero e chiamano in causa il televoto, la giuria di qualità (o morte) e la Baghavad Gita.
Ma tanto, cosa conta Sanremo? Con chi ti identifichi?
A Masterchef, invece, sono tutti in cerca di riscatto. Si sente la fame, perdonate la facile metafora. Dopo dieci anni difficili per l’economia e la società, questo programma rappresenta un’opportunità e un problema per l’Italia. Un’opportunità perché ha portato nel nostro paese un po’ di cultura della competizione e del merito.
Se vuoi vincere a Masterchef devi avere voglia di imparare e di studiare. Il risultato conta, gli esperti decidono e, almeno in apparenza, non c’è posto per mogli, arcivescovi e sottosegretari. Non sarà vero, ma sembra vero.
Un problema, perché in un Paese bloccato, di baronati insopportabili e caste, in cui gli ascensori sociali funzionano solo al contrario, fa rabbia vedere che basterebbe davvero poco per cambiare format rispetto a Sanremo. Per evitare che i giovani fuggano a Londra e Barcellona (ma possono ancora, adesso?) per fare i lavapiatti o gli astronauti.
Alla fine è proprio come diceva Boris: l’unica cosa seria in Italia è la ristorazione. Altro che canzonette.
Questo post è stato letto 867 volte






