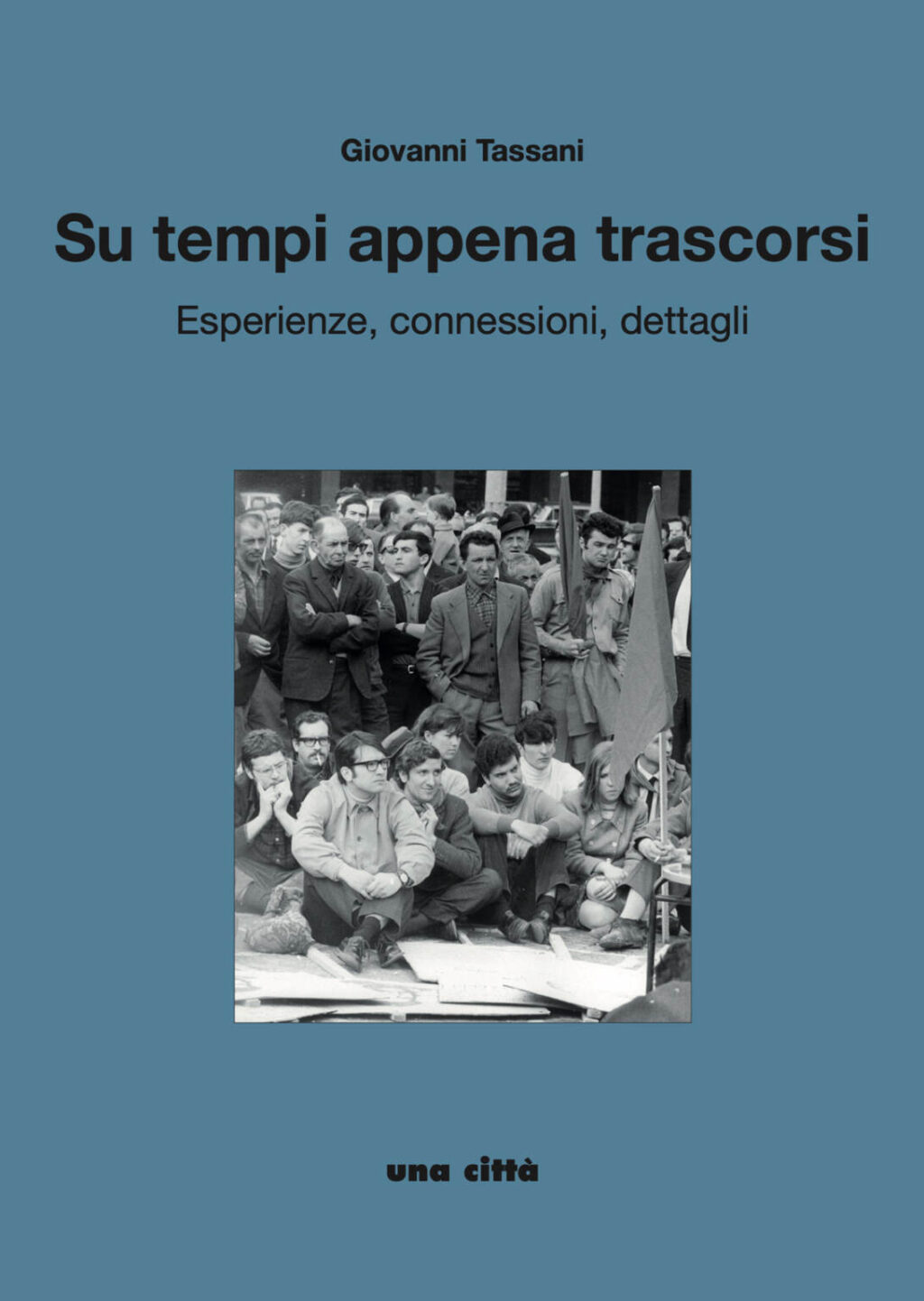
Quello che Giovanni Tassani ha scritto nel suo libro: ”Su tempi appena trascorsi – Esperienze, connessioni, dettagli” è un viaggio nella politica italiana e nel suo mondo, complesso e variegato, con un’attenzione particolare al ruolo che ha avuto il cattolicesimo e ai suoi rapporti con tutti i partiti dell’arco parlamentare.
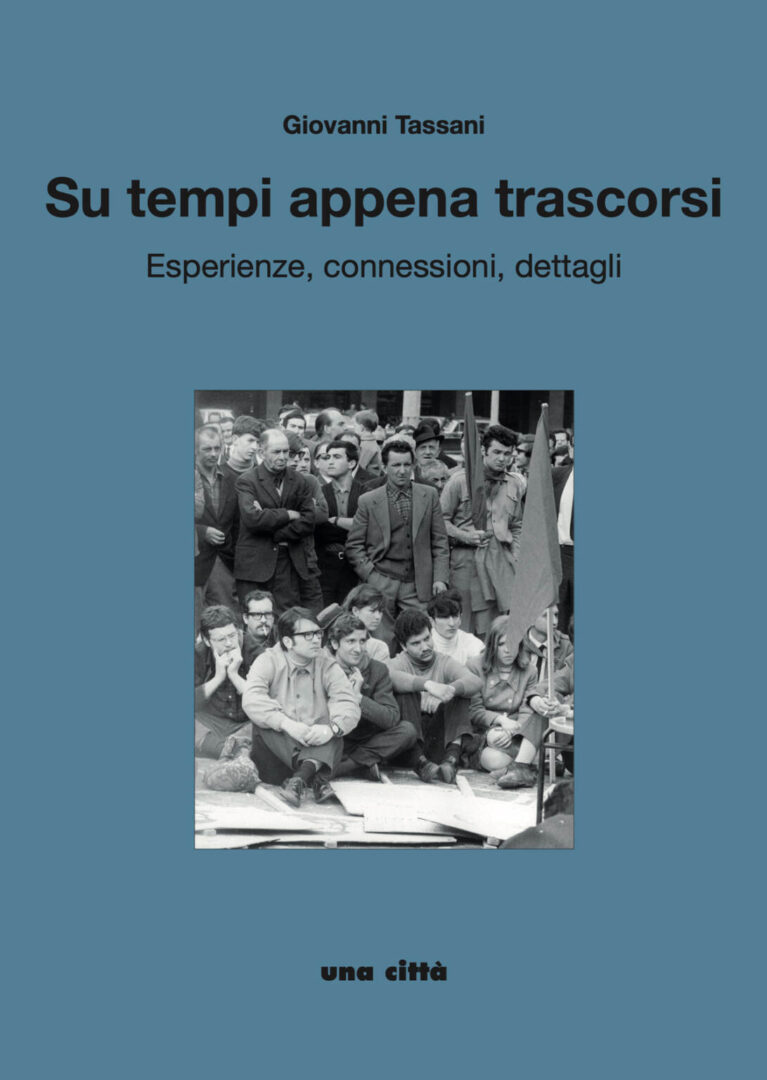
Ricercatore e studioso che si muove con dimestichezza e capacità nell’universo dell’archivistica nazionale (recentemente mi raccontava degli archivi vaticani i cui scaffali si estendono per una lunghezza di 10 kilometri…) il volume edito per i tipi di “Una Città” (cooperativa che dà alle stampe, fra l’altro, il periodico che porta lo stesso titolo e costituisce un unicum a livello nazionale per il metodo scelto di affrontare selezionati argomenti, quello delle interviste) è un excursus degli ultimi decenni ma anche oltre dove si incrociano le tante anime del mondo cattolico sia volgendo lo sguardo ai movimenti di destra sia nei suoi intrecci con le formazioni di sinistra.
Difficile seguire il filo che unisce tutte le oltre 350 pagine che lo compongono ma di sicuro il testo non esaurisce il suo percorso nella esplorazione e disamina, pur ampia, della tematica legata al cattolicesimo progressista. Nella silloge dei suoi vari interventi l’autore osserva con occhio critico i cambiamenti e l’evoluzione che hanno attraversato la politica italiana dall’inizio del ‘900 all’età contemporanea.
A mio avviso, la parte più interessante è quella dedicata al prof. Walter Ronchi, stimato medico forlivese che donò a metà degli anni ’50 una parte del suo prezioso archivio al Fondo Piancastelli della civica biblioteca. Tutto l’archivio Ronchi fu donato al Comune di Forlì, dopo la sua morte avvenuta nel 2002.
Da queste carte emerge con chiarezza il ruolo fondamentale avuto dal medico nell’esperienza di tre riviste giovanili : “Via Consolare”, “Spettacolo” e “Pattuglia” uscite a Forlì tra il ’39 e il luglio del ’43, per iniziativa del locale Guf, il gruppo universitario fascista.
Altro concittadino protagonista delle riviste fu Armando Ravaglioli, che ricoprì nel dopoguerra vari significativi ruoli fra i quali quello di capoufficio stampa del Comune di Roma e anche di Giulio Andreotti.
Il mensile “Pattuglia” è stato tra il ’42 e poco prima del 25 luglio del ‘43 quando venne fatto chiudere d’autorità da Mussolini un importante strumento culturale per tanti giovani italiani che nonostante i tempi bellici, ambivano esprimersi liberamente in campo letterario e artistico. Il merito di questo successo in campo nazionale va attribuito al suo redattore capo, Walter Ronchi non richiamato alle armi in quanto studente in medicina. Emblematica la vicenda della commedia inedita del diciannovenne Italo Calvino scovata dall’autore tra le carte dell’archivio Ronchi. Ma su “Pattuglia” scrissero anche personaggi come Testori, Ghirelli, La Capria, Strehler.
L’ultimo numero della rivista quello sul quale Mussolini decise d’imperio la chiusura e che riguardava le tendenze della pittura italiana era stato ideato da Testori.
Altro forlivese di straordinaria levatura che scriverà su “Pattuglia” è Diego Fabbri, giovane allievo della scuola di libertà di Don Pippo Prati al San Luigi dove organizza convegni e gare teatrali. Il Guf di Forlì con cui Fabbri è in contatto è un luogo di sperimentazione culturale privo di ideologia.
Preminente l’attenzione agli esponenti del cattolicesimo ma non solo. Ad esempio vi sono brani su Chiaromonte e Antonello Trombadori.
Al centro del libro un inserto fotografico con immagini tra cui spiccano quelle della famiglia Fulcieri Paulucci il cui archivio, scovato e studiato da Tassani, si è rivelato preziosa fonte per approfondire vari momenti di carattere storico della prima metà del ‘900. Tra le varie foto curiosa quella che ritrae un biglietto scritto di propria mano da De Gasperi che rimprovera il suo sottosegretario Giulio Andreotti.
Le due ultime foto dell’inserto riguardano una la chiusura della mostra sul Melozzo nel 1995 con Massimo Cacciari, il sindaco Sedioli e Gianni Baget Bozzo e l’altra Tassani insieme all’intellettuale cattolico, fattosi sacerdote in età matura, a cui l’autore, a lui legato da un rapporto di amicizia, dedica ampio spazio nel testo.
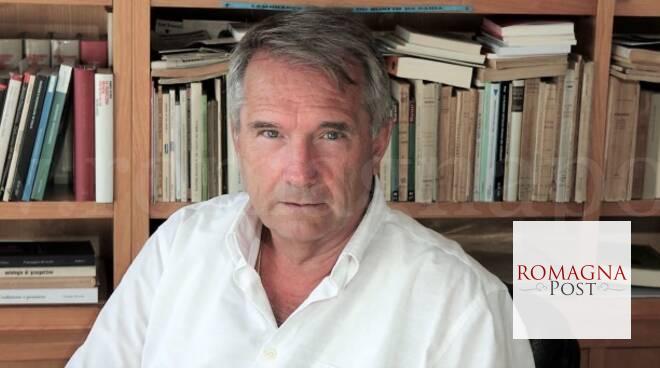
Questo post è stato letto 855 volte






